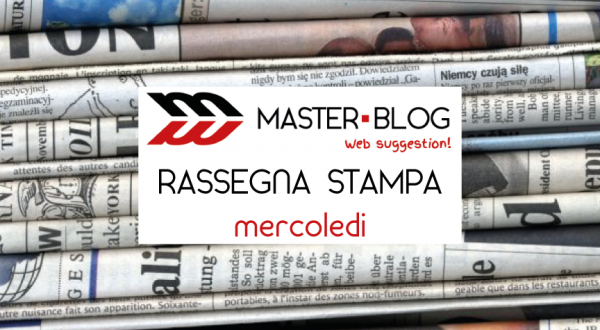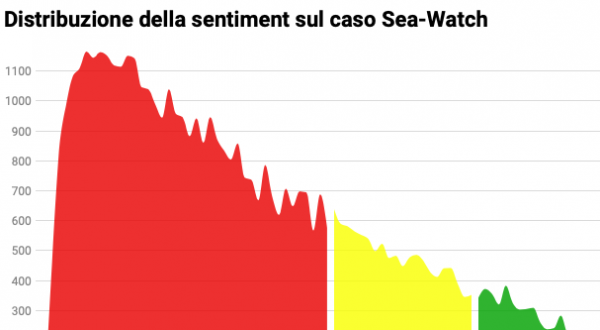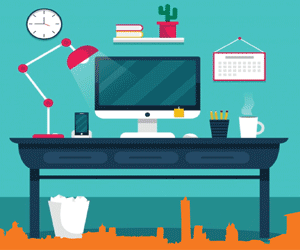Qualche tempo fa una nostra lettrice ci ha scritto, per raccontarci una sua esperienza personale che aveva però un valore quasi universale, perché si trattava di una cosa che probabilmente è successa a molte ragazze, e di cui magari non tutte riescono a parlare liberamente. Così, abbiamo deciso di pubblicare la sua storia, perchè sapere di non essere soli in certe situazioni aiuta, e poi perché volevamo dare un segnale di solidarietà: insieme possiamo cambiare le cose.
A partire da quel momento ci sono arrivate altre mail e altre storie da raccontare. Così abbiamo deciso di dare vita ufficialmente a Cara Freeda, una posta a cui ognuna/o di voi può scrivere per raccontare la propria esperienza. Quella che state per leggere è la storia di C., che ci ha voluto parlare di quel groviglio di delusione, rabbia e sensi di colpa immotivati che si prova quando si subiscono delle molestie – e di come se ne esce.
_
Cara Freeda
Ho sempre saputo che avrei voluto fare ricerca in Università e ho anche sempre saputo che non sarebbe stato un percorso facile. Diciamolo francamente: rispondere oggi, in Italia (ma non solo), alla domanda “Cosa vuoi fare da grande?” con la frase “vorrei fare ricerca”, suona un po’ come dire “vorrei fare l’astronauta.” Comunque, dicevo che ho sempre saputo che non sarebbe stato un percorso semplice e mi sono sempre sentita pronta a fare dei sacrifici in nome della fortuna di avere chiaro il mio obiettivo. Quello che non sapevo, però, era quanto sarebbe stato difficile provare a intraprendere questa carriera da donna.
Facciamo subito una premessa: quando si dice che il percorso accademico è difficile si sta dicendo che ha un iter lungo, ben preciso, molto selettivo (dove, come è noto, la selezione non è sempre basata sul merito) e spesso frustrante, perché il risultato finale non è affatto garantito, a differenza di altre professioni. Dopo la laurea il primo step di questo iter prevede l’acquisizione di titolo ulteriore: il dottorato di ricerca, a cui si accede tramite concorso pubblico. Quando ho comunicato al mio relatore di tesi che avrei voluto fare il dottorato mi ha guardata strabuzzando gli occhi e mi ha detto: “ma lei lo sa, vero, che l’accademia non è un posto per donne?” – ribadendo, tra l’altro, un concetto espresso in modo più o meno identico anche dal professore che al liceo insegnava la materia che ho poi scelto di fare all’università: “non è un campo adatto alle donne”.
Comunque le passioni sono testarde, e il bello di averle è che te ne freghi di quello che ti dicono gli altri: le persegui tirando dritto per la tua strada. Così mi sono laureata e ho iniziato a provare concorsi pubblici in tutta Italia, nella speranza di vincerne uno e riuscire a iniziare il dottorato. Ce l’ho fatta: sono entrata nell’ateneo (non quello della mia città) in cui insegnava uno dei docenti più rinomati e importanti nel mio campo di studio – non solo ci insegnava, ma era anche interno alla commissione del concorso, quindi ho avuto l’”onore” di poter sostenere il colloquio finale con lui e di poterlo scegliere come tutor della mia ricerca, cosa che ho fatto.
La prima volta che è venuto nella mia città a tenere una conferenza io sono ovviamente andata a sentirlo parlare. Avevo iniziato il dottorato da poco più di un mese e al termine della conferenza lui mi guarda e mi dice: “Hai da fare stasera? Perché mi hanno preso una stanza da letto matrimoniale: è grande, bella, potresti farmi compagnia”. Non sapendo come gestire la situazione l’unica cosa che mi viene in mente di fare in quel momento è correre da un’altra sua dottoranda per raccontarle che cosa era successo. Lo faccio e lei mi risponde: “tranquilla, è normale, lo fa sempre. Anzi, sii fiera di questa cosa perché significa che gli interessi”.
Ho passato i successivi mesi a dilaniarmi interiormente: sapevo benissimo che non c’era niente di giusto in quella cosa, eppure il fatto che tutti ne fossero a conoscenza e non la riconoscessero come oggettivamente ingiusta mi portava istintivamente a pensare che ci fosse qualcosa di sbagliato in me, e non in loro. Più mi sforzavo di farmi andare bene questa cosa più mi sentivo in colpa nei confronti di me stessa. Un circolo vizioso inframezzato da un’escalation di battute sgradevoli di cui nessuno – tranne me – sembrava accorgersi (mi riferisco a frasi del tipo: “ormai con l’età non ci vedo più tanto bene e ho bisogno di qualcuno che mi accompagni in bagno a fare pipì: vieni con me?). E più stavo lì ad ascoltarle più si acuiva dentro di me la convinzione di non valere assolutamente nulla e di aver vinto quel concorso non per una questione di merito personale, ma semplicemente per la mia fisicità. Forse una piccola parte di me, convinta di aver ingannato il sistema, ha pensato che sopportare quelle battute fosse un giusto modo per scontare la pena di un concorso vinto senza merito. Ma ognuno di noi ha una soglia di sopportazione e in questi casi più è bassa e meglio è. La mia non lo era così tanto. Ho sopportato questa situazione finché non mi sono ritrovata le mani di un uomo di 70 anni addosso, in un’aula universitaria, alle 10 e mezza del mattino, mentre cercavo di discutere i miei temi di ricerca. Con una mano ha provato a toccarmi una coscia e con l’altra una tetta. Ho reagito tirandogli una sberla e di tutta risposta mi sono sentita dire questa frase: “sai, non capisco se sei bella o se hai semplicemente qualcosa di molto erotico. Penso sia la seconda, perché se ti guardo bene non vedo bellezza”. Sono corsa fuori da quell’aula e non ho più messo piede in università per 5 mesi. Sono completamente sparita e nessuno mi ha cercata, nessuno si è chiesto come mai una dottoranda non si facesse più vedere per mesi interi. Sono stata in silenzio, non ne ho parlato praticamente con nessuno: volevo solo rimuovere dalla mia mente quel groviglio di sensazioni che mi facevano sentire responsabile di quello che mi era successo. Ho provato dei nuovi concorsi per iniziare il dottorato da un’altra parte, finché, a un certo punto, non è scattata una molla dentro di me: mi sono incazzata e ho pensato che per niente al mondo avrei rinunciato al mio posto. Così sono tornata in quell’Università, ho bussato alla porta del preside e ho chiesto un cambio formale di tutor, avviando un iter che a me è costato una immensa fatica psicologica. Quello che spesso le persone non capiscono è che il problema, quando denunci determinate situazioni, non è il fatto in sé di denunciare, ma il modo in cui reagiscono gli altri. Per me, ad esempio, non è stato faticoso raccontare quello che era successo, ma vivere le non reazioni di chi mi circondava, perché nel mondo accademico purtroppo funziona ancora che quando porti alla luce un’irregolarità diventi scomodo: da vittima di un’ingiustizia diventi tu il carnefice di un sistema alla cui conservazione sembrano tutti votati.
Non ho deciso di raccontare questa storia per lamentarmi del microcosmo accademico e delle sue dinamiche. Desiderare di farne parte è stata una mia scelta, nessuno mi ha costretto. E non ho neanche intenzione di coprirlo di melma: ho avuto questa esperienza, ma ho anche incontrato persone fantastiche, che sono state in grado di supportarmi e di ricordarmi perché io avessi scelto di perseguire questa strada, perché amassi così tanto studiare e fare ricerca. È pieno di docenti bravi e appassionati, di persone corrette e di giovani ricercatori con molta voglia di fare. Se ho deciso di raccontare la mia storia è solo perché, in quel momento leggerne una simile mi avrebbe aiutato e mi avrebbe fatto sentire meno sola, meno sbagliata e più capita. Sapere che si può uscire dal pantano di sensi di colpa e disillusioni in cui ci si ritrova quando si subiscono delle molestie mi avrebbe dato la spinta per arrivare prima in fondo al tunnel o almeno per vederne la luce. Perché la luce c’è sempre, soprattutto quando si crede in quello che si sta facendo.
C.
Source: freedamedia.it