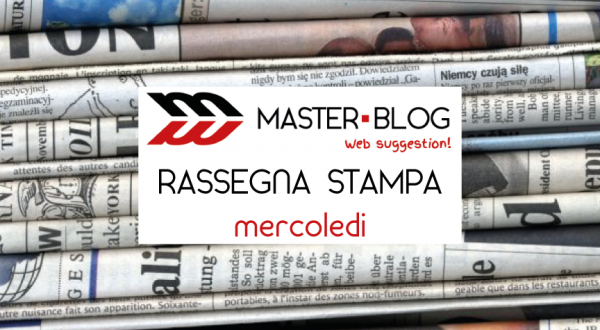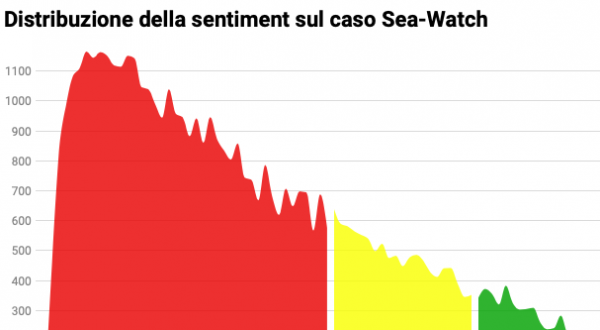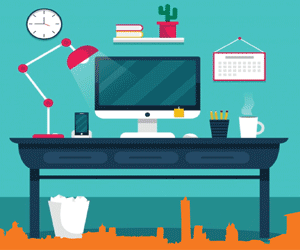I quit a great job because happiness is more important than commitment è il titolo di un articolo autobiografico comparso di recente su Quartz. Sarah Knight, l’autrice, oggi è una freelancer, ma fino a poco tempo fa lavorava a tempo pieno per una nota casa editrice. Fare carriera nell’editoria è stato a lungo il suo più grande sogno: “era la cosa che desideravo più di tutte”, racconta. E, come spesso accade, quando la fortuna si unisce alla determinazione e alla forza di volontà, a fare carriera in quel mondo lei ci è riuscita davvero. E ci è rimasta per 15 anni, lavorando di notte e spesso anche i weekend.
Ma qualcosa, che lei stessa non riusciva a mettere a fuoco, non andava. Poi, una mattina si è svegliata e ha capito: “ho capito che la cosa che desideravo davvero di più al mondo era essere felice.” Ed è stato lì, che nonostante il suo fosse un lavoro soddisfacente, ha iniziato a pensare di lasciarlo. Certo, decidere di lasciare un lavoro avviato, bello e redditizio, di questi tempi sembra una follia. E lo sembra ancora di più se non ci sono alternative a quell’impiego: lascio il lavoro, ma non so cosa andrò a fare, non ho nessun piano B, per il momento. E allora perché farlo? Questa la lista delle argomentazioni di Sarah:
Mi licenzio perché mi sento in trappola
Mi licenzio perché la vita diventa ogni giorno più breve e il tempo passa
Mi licenzio perché detesto fare la pendolare ogni giorno, all’ora di punta
Ma soprattutto mi licenzio perché sono infelice
Leggere la storia di Sarah mi ha fatto tornare in mente un video, che circolava molto qualche anno fa, e che rappresentava una realtà simile a quella di cui abbiamo appena parlato. Marina Shifrin, giovane video editor per una media company, dopo aver passato ore e ore del suo tempo a fare video, rinunciando a tempo libero e vita privata, aveva deciso di licenziarsi usando proprio uno di quei video che le stavano soffocando l’esistenza.
Questo video è uscito nel 2013. All’epoca io e i miei amici avevamo iniziato a lavorare da poco e più o meno tutti alle stesse condizioni: stavamo facendo “gavetta”, e quindi venivamo pagati poco e lavoravamo tantissimo, ben più delle otto ore canoniche. Certo, eravamo comunque fortunati perché avevamo avuto la possibilità di fare il lavoro per il quale avevamo studiato – cosa che, sappiamo bene, non tutti riescono a fare. Eppure quando “scusa, ma devo finire un lavoro importante per lunedì” è diventata la frase più gettonata dei nostri weekend, nessuno di noi era particolarmente felice, e la risposta standard a questo tipo di messaggio era sempre e rigorosamente il link al video di Marina Shifrin: “I QUIT.” Ce lo mandavamo per ridere, perché, nonostante la fatica, ci sentivamo dei privilegiati e nessuno di noi si sarebbe mai azzardato a licenziarsi davvero.
Se il video di Marina Shifrin però ha avuto così tanto successo un motivo c’è, ed è che tendenzialmente la sua condizione è comune a molti. Non è mia intenzione stare a disquisire sulla precarietà lavorativa dei giovani d’oggi, anche se è oggettivamente un problema. Non voglio entrare nel merito di questo argomento perché nel caso di questo articolo il punto è un altro: ha a che vedere con l’idea tradizionale di lavoro che ci viene inculcata in testa da quanto siamo piccoli, l’idea cioè che il lavoro non sia in alcun modo un piacere, ma solo ed esclusivamente un dovere. Un’idea, peraltro, sorretta da un altro assunto “tossico”, quello secondo cui si lavora bene solo se si lavorano 18 ore al giorno. Chi lavora di meno invece non lavora.
Personalmente mi ritengo fortunata perché faccio un lavoro che mi piace e per riuscire a farlo ho sacrificato comunque molte cose. Spesso, quando provavo a spiegare i sacrifici che ero disposta a fare, la gente mi rispondeva “tanto comunque anche il lavoro più bello del mondo prima o poi inizierà a farti schifo.” Non è vero, per fortuna. Ma se anche fosse vero, se anche un giorno il mio lavoro inizierà a farmi schifo, non penso che sarei disposta a continuare a farlo, solo perché è “un dovere”. Certo, qualcuno potrebbe dirmi che la penso così perché ho il sedere al sicuro, perché so che comunque non morirò di fame. Bè, non è così. E anche questa argomentazione fa parte di quella visione malsana del lavoro di cui parlavo poco fa, ed è malsana perché ingenera senso di colpa nei confronti di chi invece si sforza di agire con coraggio. Lasciare un lavoro sicuro, senza avere un piano B e senza avere certezze economiche, non è per niente facile: anzi, per certi versi è come interrompere una relazione d’amore che non funziona più e che non ci rende più felici. La prospettiva è quella di dover elaborare un lutto e di avere davanti un lungo periodo di solitudine e difficoltà. Sarebbe forse più facile tenersi un lavoro che non ci piace e condannarsi a non poter avere neanche un weekend libero, continuando a lamentarsi di quanto la vita faccia schifo.
Scegliere di licenziarsi perché si desidera essere – nei limiti del possibile – felici non significa potersi permettere di stare a casa a fissare il muro. No, significa invece rimboccarsi le maniche per riuscire a trovare una strada diversa, che sia più in sintonia con il tipo di persona che vogliamo essere e con il tipo di vita che vorremmo avere. E questo rimboccarsi le maniche, che in un primo momento diventa di fatto un nuovo lavoro, è qualcosa che riesce a fare non chi non ha nulla da perdere, ma chi invece ha bisogno e urgenza di trovare un altro impiego.
Certo che è difficile, ma alla fine si può fare, come dimostrano le due storie a cui ho fatto riferimento prima. Sarah oggi è una freelancer e questo significa che non ha rinunciato a lavorare, ma che è il capo di se stessa, che può decidere lei i suoi orari e l’organizzazione del suo lavoro. Marina Shifrin, invece, grazie al successo del suo video ha ricevuto molte proposte di lavoro, di cui una da Queen Latifah.
Source: freedamedia.it